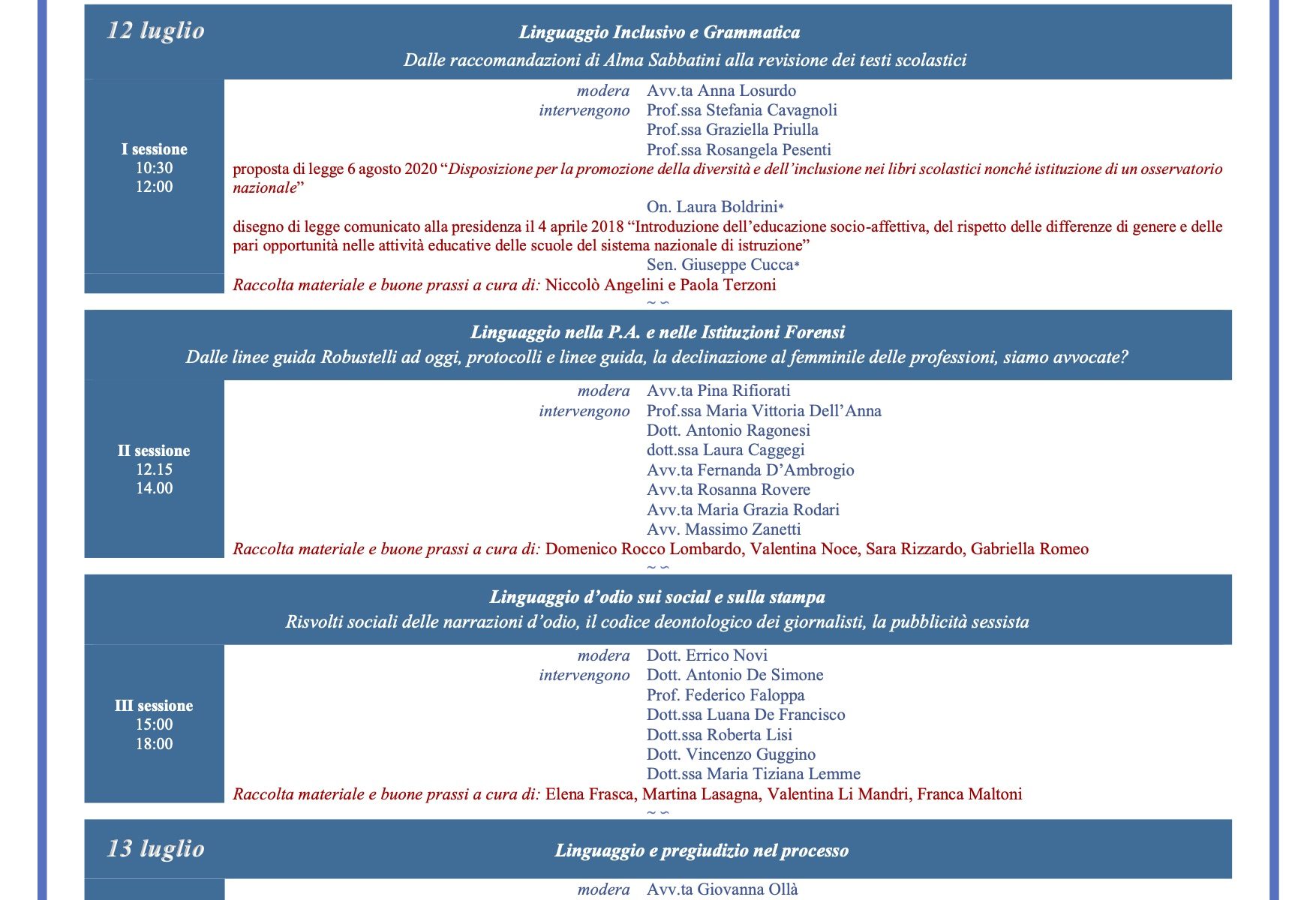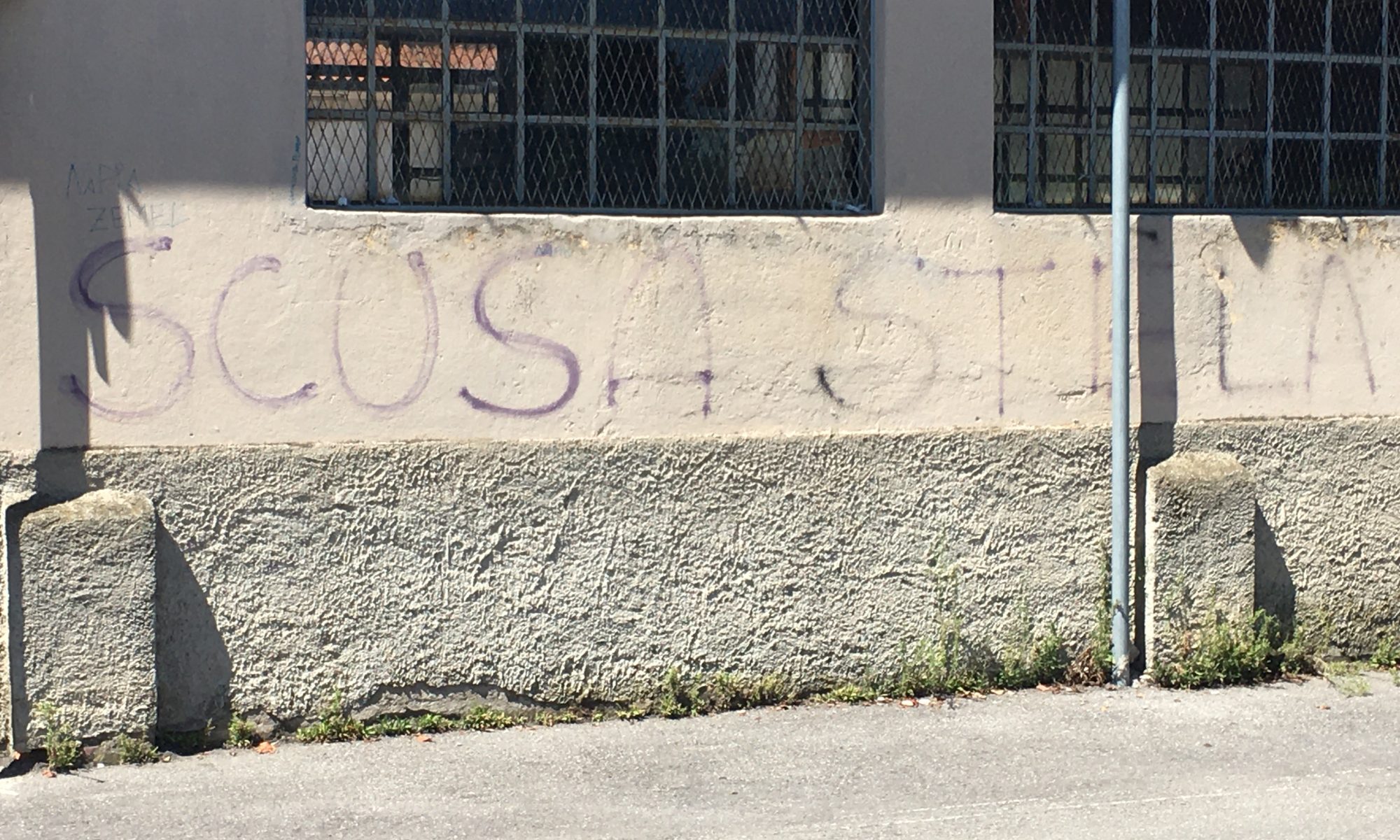Silenzio
Nei contesti comunicativi la parola è d’obbligo, non si esprimono le proprie argomentazioni con il silenzio.
Sono stata in silenzio dodici secondi prima di cominciare a parlare e dopo i primi sei ho ricevuto un sollecito, con il tono di affettuoso incoraggiamento.
Di fronte a me ho colto sui volti qualche espressione di stupore, chi mi ha invitata a questo convegno forse avrà avuto un attimo di imbarazzo.
Questo significa che noi siamo sempre immerse e immersi in un universo comunicativo in cui decodifichiamo velocemente messaggi attraverso il filtro della nostra storia, sociale famigliare linguistica.
Si dice che la comunicazione passi per il 75% dal non verbale, quindi molti messaggi entrano nel mio sistema recettivo prima che io ne prenda coscienza.
Il linguaggio non si genera nel vuoto ma dentro un’organizzazione del tempo, le strutture fisiche del luogo e una grammatica dei corpi, costituita da posture atteggiamenti espressioni abbigliamento, che eccede continuamente la grammatica della lingua definendola e ridefinendola a seconda dello spazio comunicativo che i corpi pensanti predispongono e vivono.
La prossemica e lo spazio architettonico in cui siamo prevedono che chi sta in cattedra esprima un discorso verbale e che questo discorso abbia determinate caratteristiche, che fluisca in forma argomentativa e documentata. Qualche citazione poetica potrebbe essere accolta solo a chiosa del discorso, un intero poema sarebbe un intervento straniante.
Il silenzio è imprevisto: turba, disturba, sorprende, imbarazza.
Leggi tutto “Le parole e i diritti: note a margine”
Ultima puntata di parole da casa: dedicata a Cortenuova
Parliamo continuamente di comunità: virtuali, identitarie, perfino ideologiche, nonostante sia stata dichiarata la morte delle ideologie, e non sappiamo più come vivere comunità fatte di prossimità fisica.
Superata, almeno in apparenza, la comunità che operava il controllo sui comportamenti e definiva condanne ingiuriose, ostracismi, solitudini, resta la comune fruizione di servizi a cui si accede singolarmente o nella singolitudine famigliare, chiusa come un fortilizio, e ci si ritrova come collettività in rare e sbiadite occasioni pubbliche o, al massimo, per protestare contro una minaccia.
Il coronavirus è una minaccia che ci ha chiusi in casa più di quanto non lo fossimo già e la casa, luogo fondamentale di sopravvivenza, quando è chiusa rischia sempre di diventare piccolo circuito di ossessioni, per la pulizia, per la sicurezza, per la ricchezza ostentata e mai goduta, per la dissimulazione dei problemi, luogo di reclusione agiata, di vuoto, di rituali insoddisfacenti.
Leggi tutto “Ultima puntata di parole da casa: dedicata a Cortenuova”
Costruire l’uguaglianza, liberare le differenze
Con il crollo del fascismo in Italia non è crollato il sistema scolastico, così come non sono crollate la Chiesa Cattolica o la Pubblica Amministrazione.
La guerra è passata con la sua devastazione, donne e uomini hanno resistito operando attivamente dentro la guerra di liberazione non solo per cacciare gli occupanti tedeschi, ma anche per rifondare l’Italia su un nuovo patto di cittadinanza che includesse tutti e tutte sulla base dell’uguaglianza. Leggi tutto “Costruire l’uguaglianza, liberare le differenze”
Lettera aperta al Ministro Gelmini
Tra le parole usate da Mariastella Gelmini, alle prese con le beatitudini della maternità, mi colpisce per primo il riferimento alle donne normali, alle quali lei (anormale o privilegiata?) sente di poter dare immediatamente consigli dall’alto dello scranno sul quale pensa di sedere, probabilmente per diritto biologico, ultima evoluzione di quello divino per i nuovi parvenu del potere.
La neo-mamma, fiera della sua non appartenenza a quella normalità un po’ volgare nella quale le donne normali si crogiolano, assentandosi dal lavoro prima e dopo il parto, si mette in cattedra definendo il diritto un privilegio e il suo privilegio (perché di questo si tratta quando hai un lavoro che ti garantisce, oltre ad una certa quantità di vile denaro, tutti i supporti e sostegni possibili e nessun rischio di licenziamento) un sacrificio. Leggi tutto “Lettera aperta al Ministro Gelmini”
Attacco alla scuola pubblica
La scuola pubblica è uno dei fondamenti della democrazia
La scuola è stata, in questo Paese, l’istituzione che ha realizzato più di tutte il dettato costituzionale dell’uguaglianza fra i cittadini, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli alla sua realizzazione.
Pur nelle difficoltà dovute a riforme parziali e finanziamenti sempre insufficienti, e tenendo conto delle differenze tra i vari ordini di scuola, tra i quali l’eccellenza è certamente della scuola elementare, la stragrande maggioranza delle e degli insegnanti ha lavorato per quella promozione umana sociale e culturale che ha consentito a bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di qualsiasi condizione, di crescere in un luogo in cui si sono sentiti uguali nella possibilità della differenza. Leggi tutto “Attacco alla scuola pubblica”
Della passione per le divise
Quest’estate sembra scorrere sul ritmo del ritorno delle divise, utilizzate per diffondere un’immagine di sicurezza che uniforma il paesaggio urbano delle nostre città, per fortuna in pace, a quello drammatico delle tante guerre che continuano e cominciano.
A questa passione per l’uniforme non sfugge la scuola e il dibattito delle famiglie in vacanza trova argomento di viva discussione sul tema dell’introduzione del grembiule.
Il problema della scuola, che si aggrava di ministero in ministero, perché i problemi non risolti generano problemi, diventa così una banale opinione sul look di scolari e studenti. Leggi tutto “Della passione per le divise”
A chi serve il sette in condotta?
Penso che da un dettaglio si possa capire l’insieme di cui è fondamento (così è ad esempio il DNA per l’essere umano “in carne ed ossa”) e spesso un particolare che catalizza l’attenzione può essere considerato un sintomo di un processo più complesso e dalle implicazioni più antiche.
La divisa, lungi dall’essere una tipologia di abbigliamento utile, al quale si richiamano quelli che ne interpretano la funzione protettiva per i bambini che si sporcano molto (ma allora va bene un grembiule qualsiasi, perfino fatto da sé esercitando abilità dimenticate) è un abito che disciplina il corpo perché ignorando le specificità individuali esalta l’adesione a un modello, tanto che nell’esercito le differenze gerarchiche sono segnalate da piccoli accessori fortemente simbolici e, ma questo è il mio gusto, francamente ridicoli. Leggi tutto “A chi serve il sette in condotta?”
Tra precariato e connivenza
Loro precari e noi ammutoliti.
Considero un elemento di progressiva e strisciante fascistizzazione la sequenza di corsi e ricorsi, articolati ad arte come forche caudine, alle quali devono sottomettersi i/le giovani che aspirano a diventare insegnanti, o più precisamente a uscire dal vergognoso precariato di un lavoro che spesso svolgono egregiamente già da parecchi anni.
Test, lezioni, esamucci ed esamini e la fatica di correre dalla scuola a pomeriggi noiosi e inutili, pagando onerosi balzelli, percorrendo chilometri e chilometri con rischio proprio (gli incidenti per stanchezza non sono mancati) e non solo. Leggi tutto “Tra precariato e connivenza”
A proposito di storia
Insegnare la storia: intanto invidio le maestre che sanno liberare se stesse, e i cuccioli che sono loro affidati, dal sussidiario. Come tutto il sapere anche il passato è lì, un labirinto aperto ad ogni domanda (e non è detto che la meta sia trovare una risposta) che si può percorrere scegliendo direzioni più o meno impervie, guidati dal buon senso di chi si accerta prima di tutto che ognuna/o abbia le scarpe giuste.
Alla scuola superiore libri che mi sembrano incommensurabili con le ore a disposizione appesantiscono gli zaini e i pensieri con un concentrato di nozioni che moltiplica in modo esponenziale le già numerose pagine a disposizione.
“La storia non serve a niente” afferma convinta Sabrina, la più studiosa dei miei bru-bru lisciando i capelli fino allo sguardo vagamente disgustato che si posa sul libro, “servono di più le discussioni”. Leggi tutto “A proposito di storia”
Tempi di scuola
Iniziativa per la Giornata della Memoria: accompagno la mia classe, una quinta superiore, insieme alle altre dell’Istituto, al cinema. Abbiamo scelto “Il pianista”.
Già dopo i primi minuti nella sala nessuno fiata, avverto la tensione crescente in me e in loro come un sentimento che ci accomuna.
A metà film, mentre scorrono le immagini della deportazione dal ghetto, l’orologio mi ricorda il “cambio dell’ora”.
L’organizzazione scolastica ci prevede come semplici accompagnatori (e forse hanno fatto bene i due colleghi rimasti fuori dalla sala a chiacchierare!), sarebbe stato troppo complicato ristrutturare il lavoro di tanti insegnanti in questi tempi in cui l’orario è completo per tutte le cattedre e nessuno ha più ore “a disposizione”.
Mentre esco l’emozione si trasforma in una rabbia così profonda che temo di non saperla controllare. Leggi tutto “Tempi di scuola”