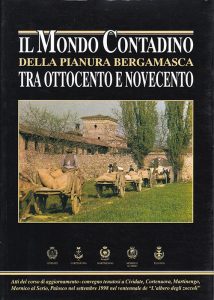
IL RUOLO DELLA DONNA NEL MONDO RURALE
In: Il mondo contadino della pianura bergamasca tra Ottocento e Novecento – Convegno 1998 (a cura di Riccardo Caproni e Tarcisio Marino Caffi), Corponove, 2000
Parto dal titolo di questa conferenza che rappresenta un po’ un’anomalia rispetto agli altri temi perché contiene un soggetto, la donna, mentre gli altri titoli sono declinati in modo “neutro”: il mondo contadino, la religiosità, l’istruzione.
La donna quindi, ad una prima lettura, sarebbe un tema tra i tanti, uno degli aspetti di questo mondo contadino, forse una caratteristica che ci consente di ricomporre il quadro, un’aggiunta che approfondisce ma non modifica la lettura d’insieme.
Nel mondo contadino, invece, le donne non possono essere considerate come una delle tante variabili perché ne sono, si potrebbe dire, parte costitutiva, elemento fondativo.
Non esiste il mondo contadino senza le donne così come non esiste il mondo stesso e la sua storia senza le donne, anche se quando si fa una storia “generale” come questa il posto che ci viene assegnato direi che è un recinto, un ghetto, citando Arlette Farge, dal quale spesso non si esce indenni.
Entrare in merito al tema significa perciò accettare e nel contempo forzare questo ghetto se non voglio correre il rischio di contribuire alla trasmissione di questa visione aggiuntiva, e mi verrebbe da dire anche ancillare, della parte femminile della storia.
Per continuare con Farge “parlando delle donne e della loro storia, non si tratta neppure di riempire uno spazio bianco perché non c’è nessuno spazio bianco da riempire: bisogna solo ripassare con la matita nera i segni cancellati il cui tracciato è, però, ancora bene individuabile, di un disegno di cui nessuno si è preoccupato mai”. (1)
La prima operazione da fare è quella di cancellare la parola ‘donna’ e mutarla con il plurale ‘donne’: il passaggio può sembrare irrilevante, ma nella mente di noi parlanti la lingua non è neutra, “(…) allo stato in cui ognuno riceve la lingua e la usa, questa racchiude e propone una data visione del mondo. La lingua – soprattutto nel modo in cui viene realmente praticata dalla maggioranza dei parlanti – è un binario su cui viaggia il pensiero. E’ d’altronde questa la sua funzione perché la lingua deve ‘orientarci’ nel mondo; ma dobbiamo renderci pienamente conto di questa sua azione se vogliamo che la nostra mente conservi il controllo di se stessa e non cada sotto l’effetto degli automatismi linguistici”. (2)
Se muta la lingua muta completamente il modo in cui si costituiscono, dentro di noi, le immagini del mondo e quindi anche del passato, in questo senso singolare e plurale non solo non si equivalgono, ma segnalano modi di guardare noi stessi egli altri, le altre, profondamente diversi.
Non esiste la donna come modello reale, calco immodificabile di caratteristiche che si ripetono uguali nei singoli soggetti, che scompaiono in quanto tali a favore di un eterno e semplicistico stereotipo; esistono le donne, ed esiste semmai il modo individuale e originale col quale ognuna si è confrontata e misurata e scontrata con gli stereotipi e le immagini correnti del femminile e con le condizioni materiali offerte al proprio genere in una data situazione e società.
E questo vale anche per gli uomini ma si aprirebbe un altro discorso.
L’aggettivo contadina quindi, accostato alla donna, dice di una condizione agita in mille variabili nello spazio e nel tempo, condizione lavorativa tra le più lunghe dell’umanità, e quindi delle donne che ne sono la metà, anche se dovremmo sapere che proprio nel mondo contadino le donne rappresentano, come forza lavorativa, ancora oggi sul pianeta, molto più della metà.
Non si tratta perciò semplicemente di mettere a tema le donne come soggetto storico, quanto piuttosto di rileggere la storia e, a maggior ragione, le storie, dell’agricoltura e non solo, tenendo conto dei due generi, degli uomini e delle donne che insieme abitano questa terra e delle relazioni tra i due generi che strutturano i rapporti di potere, la divisione del lavoro, la distribuzione delle risorse e le forme stesse di riproduzione e sopravvivenza della specie.
Lo stesso divenire della società e delle persone si struttura dentro i codici, le culture, i ruoli che modellano l’essere uomini e donne in un dato tempo e spazio, ed è anche a partire dal rapporto tra i due generi che una società costruisce i suoi caratteri fondamentali, dai vissuti individuali quotidiani ai processi di simbolizzazione gerarchica nelle forme della comunicazione e del potere.
Essere donne e uomini sembra un dato naturale proprio nella misura in cui è il risultato di un costante e ininterrotto processo di apprendimento che ridisegna di volta in volta in modo diverso lo scarto tra dato biologico (o come questo “dato” viene definito) e il divenire storico di ognuno e ognuna, così come delle società.
Narrare il passato, e ancora di più nella funzione dell’insegnamento, è qualcosa che riguarda direttamente il rapporto tra adulti/e e giovani generazioni, tra patrimonio che vogliamo lasciare in eredità e competenze da favorire perché quel patrimonio sia interamente fruibile e comprensibile.
Una responsabilità quindi che ci chiama in causa come uomini e donne, e non possiamo sottrarci, proprio nella scuola, alla consapevolezza di quale saper essere, e non solo sapere, propone ad allievi e allieve il nostro modo di muoverci nel mondo, di parlare, ridere, tacere, giocare, amare, interrogare, pensare, sognare…il nostro esistere insomma, segnato anche da quell’appartenenza di genere che per ognuno e ognuna si gioca sempre tra permanenze e mutamenti, norma e trasgressione, adesione e ripensamento, necessità e scelte.
Si tratta del nostro “essere” che, come sappiamo, è direttamente connesso con il sapere, con ciò che sappiamo di noi, del nostro passato, con le immagini che dentro di noi deposita il passato raccontato e l’esperienza del presente.
La prima operazione storica è quindi “linguistica”, alla parola uomo non corrispondono immagini femminili, se parliamo di uomo primitivo, di garibaldini, di contadini, l’immagine che si deposita è inequivocabilmente maschile e studiare il femminile diventa appunto quell’operazione aggiuntiva, accessoria, di cui parlavo all’inizio, un capitolo, se va bene, ogni tanto, nel manuale, una monografia che, sempre per dirla con Arlette Farge, spesso ancora appare sui tavoli delle librerie in mezzo al ventaglio delle minoranze etniche, nazionali, religiose, ecc.
L’operazione linguistica però, per quanto fondamentale, non basta alla conoscenza storica che richiede insieme una ricerca puntuale sulle fonti e una rivisitazione di molti dei criteri e dei percorsi della ricerca, perché l’invisibilità storica delle donne non riguarda solo la censura e/o l’ignoranza, più o meno voluta, delle fonti che le riguardano, ma molto di più i criteri storiografici della ricerca, gli interrogativi che la guidano, le ipotesi che la sollecitano, le curiosità che la sostengono, e direi pure le condizioni materiali che la consentono, perché i libri sono anche un prodotto di mercato con tutto ciò che precede e consegue.
“Diventa importante” dice Arlette Farge “dissodare la storia in modo diverso, andando a ricercare, nel succedersi degli avvenimenti, nei comportamenti e nei sentimenti collettivi, i punti su cui le analisi storiche hanno costruito l’economia dell’inevitabile rapporto tra il maschile e il femminile”.(3)
Diventa a questo punto generico parlare della condizione della donna contadina, anche se vogliamo restringere il campo al tempo e al territorio definito dal film “L’albero degli zoccoli”, che ci ha fornito l’occasione per questa riflessione.
Dovremmo approfondire il rapporto specifico delle donne con l’agricoltura, le condizioni di lavoro e le posizioni in rapporto alla distribuzione delle risorse, alla loro gestione, al loro uso, il rapporto interno alle famiglie in relazione all’età, alla posizione filiale, allo stato civile, nubile o coniugata, le strategie relazionali dentro le specifiche strutture agricole, nelle forme degli insediamenti, qui da noi nella cascina, nel paese, nel rapporto con la religione e con la Chiesa. E dovremmo approfondire le ragioni dell’invisibilità storica e sociale di queste donne, in un settore nel quale la loro presenza è del tutto evidente.
Come insegnante cerco di ricordare che le fitte righe dei manuali nascondono un vuoto che, evidenziato opportunamente, li renderebbe per buona parte muti e inutilizzabili.
E’ ancora una storia di eventi e di piccoli gruppi definiti dall’accesso al potere e/o al privilegio sociale, mancano tra i soggetti, ancora troppo spesso, le classi subalterne, i ceti che non hanno lasciato memoria scritta e del cui agire, anche politico, non abbiamo documentazione diretta.
Mancano le donne ovviamente e manca troppo spesso, dobbiamo dircelo, quella capacità didattica di risvegliare nei ragazzi e nelle ragazze la curiosità per un passato che li riguarda direttamente perché non parla solo di “là e allora”, ma parte da un “qui ed ora” delle loro domande, della loro vita, collocata in un territorio e in un tempo che hanno bisogno di comprendere, per capire ciò che li connette ad un più lungo tempo alle loro spalle ed un più ampio spazio che oltrepassa confini e culture diversi.
Nella scuola troppo spesso alla ripetizione dei contenuti si accompagna un deficit di “strumentazione” che non consente di tramettere competenze utili a trovare nelle categorie di lettura del passato criteri e informazioni che illuminano il presente o almeno aiutano nelle scelte complesse e obbligate che orientano la scoperta/costruzione della propria identità.
Per tornare alle donne nel mondo rurale vorrei fornire alcune tracce per delimitare il percorso utilizzando le citazioni felicemente scelte da Paola Di Cori per il volume “La donna rappresentata”.
Il testo elenca in ordine alfabetico, e descrive, i lavori delle donne con lo scopo esplicito di “illustrare con una grande varietà di esempi sparsi nel tempo e nello spazio alcuni modi in cui è possibile affrontare il problema di una specificità del lavoro delle donne” (4) sottraendo, aggiungo io, le donne alla persistenza dell’immagine sterotipata di un casalingato subalterno, muto e insignificante per la storia.
Alla voce “Contadina” sono riportate tre citazioni estremamente significative dal punto di vista del contenuto ma anche della scelta e collocazione storiografica.
La prima è la voce di Edith Ennen per quanto riguarda l’Alto Medioevo Europeo: “Nella famiglia contadina (…) la donna preparava il bagno, macinava il grano con la macina a mano, produceva la birra, cucinava e puliva, ma prestava anche il suo aiuto nel vigneto del signore, nella raccolta di bacche nel bosco e nei lavori per il raccolto cerealicolo.
Stando all’admonitio generalis del 789, che concerneva la santificazione della festa, una serie di opera servilia era severamente interdetta di domenica (…). Alle donne si vietava di compiere opera textrilia – termine con il quale si intendevano tutte le fasi, dalla raccolta delle piante fibrose alla realizzazione di un pezzo di abbigliamento completo – e quindi non potevano tagliare abiti, cucire o cardare la lana, battere il lino, lavare in luoghi pubblici e tosare le pecore. Mentre in questo documento i lavori dell’orto venivano attribuiti all’uomo, in un’altra fonte il vescovo Meiwerk rimproverava la donna di un suo impiegato per non tenere in ordine l’orto che era pieno di erbacce e di ortiche. I lavori di cucito non si limitavano affatto alla preparazione di capi d’abbigliamento indispensabili per la propria famiglia; le donne erano infatti tenute a collaborare ai lavori necessari al signore fondiario. (…) Il loro lavoro si doveva svolgere tutto nella casa contadina”. (5)
Vorrei insistere sul Medioevo, anche se i limiti di tempo consentono solo brevi accenni alle questioni, perché il binomio “donne e lavoro” era un accostamento “doppiamente mortificante, quando si pensi che su entrambi i termini della coppia cadeva allora un pesante marchio di svalutazione. Da un lato anche le antropologie più moderate non misero mai in discussione la “naturale” inferiorità della donna rispetto all’uomo; dall’altro, fu allora largamente accettata la concezione del lavoro che non fosse intellettuale in termini tutt’altro che positivi, interpretandolo prevalentemente come negazione dell’otium e come necessità derivante dal peccato originale. (…) Con il passaggio dall’alto al basso Medioevo si può parlare a ragion veduta di un sostanziale peggioramento nel riconoscimento del lavoro delle donne e nelle loro possibilità lavorative. Siamo così alle soglie del loro confinamento entro le mura domestiche, nell’ambito di un disegno ambiguo, nel quale confluivano motivazioni di tutela delle donne e intenti di limitazione della loro sfera d’influenza.
Proprio in epoca medievale sembra essersi costituita la cornice interpretativa del lavoro femminile.” (6)
Una cornice di lunga durata se ancora oggi facciamo fatica a ricostruire la specificità, la dimensione e l’importanza del lavoro femminile in tutti i settori, e proprio a partire da quello agricolo, una cornice che certo ha influenzato fortemente non solo i percorsi di ricerca ma anche la visibilità, la disponibilità e la costituzione stessa delle fonti.
Non sono una ricercatrice ma credo siano poche, ancora oggi, le testimonianze dirette della condizione contadina da parte delle donne stesse, per le quali, ancor più che per altre categorie di lavoratrici, vale l’osservazione di Marina Vitale “Sui tentativi di organizzazione autobiografica della propria esistenza da parte delle donne lavoratrici continua a gravare una doppia interdizione: di sesso, oltre che di classe; un’interdizione profondamente interiorizzata dalle donne stesse, un’inibizione psicologica che agisce più e prima dell’incapacità tecnica di scrivere o anche solo di ordinare materialmente la propria storia”.(7)
Quando ognuno e ognuna di noi disegna la propria storia può sperare che alla fine appaia quella cicogna, come desiderio di senso e compiutezza, di cui narra Karen Blixen in un famoso racconto, ma troppo spesso la nostra mano è costretta e guidata dentro una cornice che non ci appare come modificabile costruzione umana, ma piuttosto come un obbligato confine naturale. (8)
Per le donne il confine è segnato dalle condizioni materiali di vita, dalle norme che regolano l’accesso alle risorse, dallo spazio di movimento consentito in una data società, dalle relazioni possibili e praticabili.
La seconda citazione per la parola “Contadina”, nel testo di Paola Di Cori, riguarda l’Emilia nei secoli XVIII-XIX: “Le donne (…) si trovavano a ricoprire nelle economie familiari appoderate ruoli differenti, sempre tuttavia gerarchicamente inferiori a quelli maschili. Ma quali meccanismi determinavano questa asimmetria di potere tra i sessi? Uno dei più importanti riguardava il diverso accesso al patrimonio, che in quei contesti assumeva forme tipiche e molto indicative della diversa collocazione dei soggetti nell’ambito domestico.
Le economie familiari dei mezzadri, dei piccoli proprietari e degli affittuari coltivatori davano vita infatti ad una forma di proprietà, denominata dai giuristi ‘comunione familiare’ tacita e regolata da norme consuetudinarie, la cui efficacia assumeva particolare evidenza in occasione della divisione tra le varie stirpi, un evento assai frequente nel corso dell’Ottocento. (…) Nelle opere dell’avvocato bolognese Girolamo Calzolari (1709) e del giureconsulto fiorentino Gregorio Fierli (1796) viene sancita la totale esclusione delle donne dalla comunione tacita familiare. Scrive Fierli che i soci sono quei membri della famiglia che hanno riconosciuta ‘dalle leggi la potestà di obbligarsi’, con esclusione quindi di ‘minori, furiosi, mentecatti e femmine’.” (9)
La cornice, per restare nella metafora, diventa sempre più rigida e ingombrante.
Siamo alla vigilia della Rivoluzione Francese e vale la pena di ricordare in questa sede che solo qualche anno dopo, nel 1992, alla proposta di Olympe De Gouges, all’Assemblea nazionale francese, di una carta dei ‘Diritti della donna e della cittadina’ che sancisse anche per le donne quell’uguaglianza appena proclamata, consentendo l’accesso alla tribuna, così come già esisteva quello al patibolo, la risposta fu la ghigliottina e il passaggio dalla “sudditanza” alla “cittadinanza” verrà segnato da una discriminazione che ancora oggi agisce e interroga il patto sociale e le costituzioni esistenti.
Nella diversità degli insediamenti e delle caratteristiche dell’agricoltura che dividono l’Italia in tre tipologie principali, l’area del latifondo, quella mezzadrile e quella della grande cascina padana, la condizione delle donne appare analoga in tutta la penisola: ad una “minorità” sancita dalla legge, che ha escluso per anni le donne dalla successione patrimoniale e dal controllo dei frutti del proprio lavoro, corrisponde l’indispensabilità della presenza femminile nel mondo contadino, presenza che costituisce il vero cemento dell’unità familiare e spesso la garanzia della continuità.
Come dice con efficacia Amalia Signorelli “Il lavoro delle donne contadine può essere considerato a buon diritto una delle aree più vistosamente malconosciute della condizione femminile. Certi luoghi comuni quasi del tutto privi di riscontro oggettivo, come il confinamento delle donne in casa, sicchè si sarebbero dedicate ai lavori domestici e al più a quelli dell’orto e della bassa corte; o quello che le vuole escluse, per uso antichissimo addirittura consacrato da tabù, delle due operazioni più pesanti ma anche più importanti economicamente e simbolicamente del ciclo della granicoltura, l’aratura e la mietitura – tali luoghi comuni hanno trovato un credito tanto ampio quanto scarsamente giustificato. (…)
Si deve al nuovo ‘sguardo’ maturato negli anni settanta con la ricerca di ispirazione femminista, se ci si è resi conto delle reali dimensioni della ‘fatica’ femminile. C’era, innanzi tutto, il lavoro di riproduzione. Quello che era necessario svolgere nelle condizioni di vita più o meno generali delle campagne italiane del dopoguerra, era enorme: prestazioni sessuali coniugali come diritto maschile e dovere femminile, l’aborto come unico mezzo efficace di controllo delle nascite; abitazioni, quando non sovraffollate e malsane come spesso accadeva, comunque ancora quasi sempre prive di servizi, compresa l’elettricità, l’acqua corrente, bagni e servizi igienici, necessità di integrare il reddito familiare producendo direttamente per l’uso cibi conservati e calze di lana, materassi, imbottite e maglie, corredi da sposa e capi di vestiario; cura dei piccoli, cura degli ammalati e degli anziani e, nei limiti consentiti dalle condizioni di vita, responsabilità della sopravvivenza e del benessere di tutti i membri della famiglia.
C’era poi il lavoro femminile direttamente ‘produttivo’. Le donne in campagna non si limitavano a spigolare e vendemmiare, ma vangavano e sarchiavano, se necessario aravano, seminavano e mietevano, governavano il bestiame e trasportavano grossi carichi. Di fatto, non erano escluse da nessuno dei lavori cosiddetti pesanti. Una caratteristica delle donne contadine che raramente è stata messa in evidenza è la capacità-disponibilità che avevano, spinte dal bisogno ma al tempo stesso dotate di una duttilità e di un’inventiva notevoli, di assumere i ruoli produttivi più svariati: negli interstizi che lasciava loro il lavoro di casa e quello agricolo riuscivano a ‘guadagnare qualche soldo’ facendo ogni sorta di cose: raccoglitrici-venditrici – talvolta al mercato locale tal’altra direttamente alle ‘signore’ del paese o della città vicina – dei prodotti selvatici (fragole, funghi, erbe,ecc.); produttrici-venditrici, alle stesse condizioni, dei prodotti della bassa corte e dell’orto; venditrici delle proprie competenze di massaie e di cuoche, in prestazioni saltuarie o fisse, alle stesse ‘signore’ o anche a vicine impossibilitate o, comunque, a chiunque volesse comprarle; persino manovali nella piccola edilizia autogestita locale”. (10)
Ho voluto riportare questa lunga citazione perché mette in luce con efficacia e precisione la fatica, ma anche la complessità e la creatività del ruolo della donna contadina, alla quale erano richieste competenze come la flessibilità, la capacità di improvvisazione, di adattamento, di riprogrammazione del tempo e delle risorse, di individuazione delle opportunità, di amministrazione dei beni e dei saperi famigliari, di gestione delle relazioni, che possiamo considerare di grande modernità.
Una storia di lunga durata, potremmo definirla, soprattutto lunga durata delle immagini, della mentalità, delle stereotipie, forse più che delle stesse norme e tradizioni, ma in questa storia è depositato anche un patrimonio di capacità e intelligenze che non possiamo permetterci di sprecare, cancellandone la memoria e sottovalutandone il valore.
Sfatato ormai, si spera, il pregiudizio del senso comune, secondo il quale il lavoro femminile sarebbe una delle conseguenze della modernità, proprio anche attraverso la ricostruzione della presenza femminile in agricoltura, resta la necessità di andare oltre il dato puramente lavorativo per cogliere la complessità di una presenza che, come dicevo all’inizio, non può non segnare tutti gli aspetti della società e quindi della storia.
Proprio cominciando dall’analisi del mondo rurale, possiamo cogliere la relazione tra “patrimonio e matrimonio” per dirla con una battuta, questione che intreccia alla struttura lavorativa quella delle relazioni parentali e affettive dentro norme e tradizioni, la gestione della sessualità femminile e insieme le strategie per conservare forme d’indipendenza o addirittura preservare scelte di solitudine, la trasmissione tra generazioni di donne dei saperi tradizionali, ma anche dei ‘permessi’ di trasgressione ed emancipazione nel rapporto madri-figlie.
L’analisi di un mondo contadino, solo in parte forse scomparso e trasformato, la cui continuità nei secoli è arrivata così vicina a noi, tanto che ne sopravvive ancora la memoria, non può prescindere oggi dall’ascolto della diretta voce dei protagonisti e delle protagoniste.
La voce anche di sofferenze mai dichiarate, come ricorda Gianluigi Della Valentina, all’inizio del suo bel saggio sul lavoro femminile nel Bergamasco di fine Ottocento (11) e vorrei riportare, come testimonianza significativa, proprio le parole di una delle donne intervistate da Nuto Revelli per il suo libro “L’anello forte” opportunamente riportata nel testo, già citato, di Paola Di Cori.
“Ah, io non vorrei più tornare indietro, oh, la vita che ho fatto. Io di bello ne ho visto poco. (…)” dice Anna Gazzera “Una volta era una martire la donna di campagna, una martire. Perché gli uomini andavano via in campagna, allora falciavano tutto a mano, anche l’uomo era martire perché lavorava tutto il giorno e di notte veniva l’acqua da irrigare. E la donna a casa aveva le vacche da mungere, ed i bambini da guardare, e poi il burro da fare, io non le posso spiegare tutto, passavo quasi tutte le notti senza dormire, poi ti viene il nervoso, la debolezza, perché quando uno fa questa vita non ha più voglia di mangiare, uno si lascia andare. Poi abbiamo migliorato, non vendevamo già più le uova per comperare lo zucchero, non per dire ma stavamo bene, in casa mancava niente, avevamo i nostri liquori, lo zucchero, il caffè, il formaggio, ammazzavamo il maiale, c’era di tutto. Ma non potevamo più gustare la roba perché ormai eravamo stanchi, sfiniti, logori, non dormire, tanto lavoro, i bambini che piangevano, che si aggrappavano alla sottana, no, no, la donna di campagna al tempo nostro era una martire, adesso è meno sacrificata perché ha le macchine, e poi le famiglie non sono più grosse. (…) Oh, una volta erano tante le famiglie numerose come la nostra. Una volta c’erano i preti, e le madri avevano paura di fare peccato. E poi è arrivata l’epoca del duce, dava ancora il premio a quelle che ne compravano tanti.” (12)
Testimonianza simili possiamo ritrovare negli studi, non proprio numerosi comunque, non solo dal nord al sud dell’Italia, dalla montagna alla collina, alla pianura, ma quasi certamente dalla Francia alla Spagna, dalla Grecia alla Russia, e più lontano ancora, come ci ricordano le testimonianze delle donne latino-americane o delle africane o delle indiane.
Studiare la condizione della donna rurale può diventare una sfida storiografica con profonde valenze politiche, se la politica è pensata e praticata come il luogo di un patto tra i generi e le generazioni, che si occupa della convivenza civile anche attraverso la gestione delle risorse, della loro produzione e distribuzione secondo criteri di giustizia sociale.
Pur restando nel piccolo spazio di questa conversazione, che mi costringe a sintesi veloci e generalizzazioni un po’ grossolane, non possiamo costringere il nostro sguardo entro i confini di un territorio provinciale e neppure nazionale, perché la storia risponde prima di tutto alle domande del presente, nel quale trova le sue radici e il suo senso un presente, il nostro, che può tenere nel cuore l’albero degli zoccoli, ma tra le mani ha ormai la responsabilità delle sorti dell’intero pianeta.
Ho citato il film perché ancora, a distanza di tempo, riporta a molti/e di noi le atmosfere del proprio passato, tanto poco erano cambiate le condizioni del mondo contadino, nelle nostre zone, dall’Ottocento agli anni cinquanta del Novecento.
Alla tenerezza che risvegliano le immagini, che a molti/e di noi riportano schegge d’infanzia, resta per me, oggi come allora, un sottile senso di incompiutezza, qualcosa che non quadra, un disegno dai contorni sfumati che celano altre e diverse immagini e verità.
Resta nella narrazione cinematografica il tabù di una presenza femminile più reale nell’espressione della sua esistenza: mancano i conflitti con gli uomini, ma anche tra donne, così come le scelte forti, le solidarietà, c’è la maternità, ma è taciuto il desiderio sessuale dietro una compostezza della figura della fidanzata che ricorda l’immagine quasi asessuata della Lucia di manzoniana memoria, c’è il corteggiamento garbato ma è assente quella promiscuità tra i sessi che intrecciava anche strategie di seduzione e forme di sopraffazione o violenza.
Non si può chiedere ad un film di essere testimonianza storica, ma solo opera compiuta della creatività del regista e sono altri i criteri attraverso i quali leggerne il senso e il valore, pure mi piacerebbebbe ritrovare sullo schermo la forza, la risolutezza e anche la durezza, quel mascherare l’affetto dietro un’attenzione un po’ ruvida, di alcune donne della mia infanzia in cascina, quelle donne lombarde, che non sono diverse da altre, certo, ma che vorrei ricordare, come suggerisce Annarita Buttafuoco, “in un tratto non sintetizzabile in un’immagine unica, ma composto dalla sovrapposizione di diversi elementi. (…) quell’attitudine che in termini ottocenteschi si sarebbe definita ‘morale’ e che, in un’estrema semplificazione, potremmo indicare come la tendenza diffusa delle donne lombarde ad ‘assumere responsabilità’ verso se stesse e verso la società in senso lato.” (13)
Non sono una studiosa o una ricercatrice, potrei definirmi una fruitrice appassionata di ricerche altrui, perché credo che sia parte integrante del mio ruolo d’insegnante la capacità di rendere visibili i contributi che le ricerche stesse ci forniscono senza accontentarmi delle pastette precotte, e non sempre ben confezionate, dei manuali, ma con la passione di accompagnare allieve e allievi alla scoperta di tutte le possibilità che ci offre la “libera proliferazione delle domande” e per questo vorrei aggiungere, sul tema, una piccola nota relativa alla cosiddetta preistoria, ricettacolo di molti degli stereotipi che restano inossidabili nell’immaginario dei nostri ragazzi/e da un ciclo all’altro della scuola.
Se è vero che nei primordi della nostra storia gli uomini erano cacciatori e se è stata la raccolta dei frutti, però, più che la caccia, come appare probabile, a consentire alla specie umana di sfamarsi, è alle donne che dobbiamo in buona parte la sopravvivenza e, successivamente, l’invenzione dell’agricoltura.
Non è stata un’invenzione da poco, ne conosciamo l’origine in modo approssimato come per molte altre questioni di cui non ci resta testimonianza, ma può rappresentare un’occasione per ricollocare il nostro sguardo in modo meno strabico perché riesca a vedere entrambi i generi nella storia e forse a svelare quei lati oscuri del passato che portano la loro ombra anche sul nostro presente e rendono opaca la possibilità di immaginare il futuro.
Rosangela Pesenti
1) Arlette Farge, La storia senza qualità, Essedue edizioni, Verona, 1981. Titolo originale “L’Histoire sans qualité” Paris, éditions Galilée, 1979, p. 17
2) Francesco Sabatini, Più che una prefazione, in Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1987
3) Arlette Farge, cit., p. 19
4) Paola Di Cori, La donna rappresentata, Collana IRES, Ediesse, Roma 1993, p. 103-104
5) Edith Ennen, Le donne nel Medioevo, Laterza, Bari, 1990, pp. 117-118
6) Maria Giuseppina Muzzarelli, Paola Galetti, Bruno Andreolli (a cura di ), Donne e lavoro nell’Italia medievale, Rosemberg & Sellier, Torino, 1991, pp. 7 e 10-11
7) Marina Vitale, Una donna dalla memoria lunga: la scrittura autobiografica dal basso, in A. Arru e M. T. Chialant, Il racconto delle donne. Voci, autobiografie, figurazioni, Liguori, Napoli 1990, p. 93
8) Karen Blixen, Ultimi racconti, Adelphi, Milano 1995
9) Maura Palazzi, Famiglia, lavoro e proprietà: le donne nella società contadina fra continuità e trasformazione, in Annali dell’Istituto Alcide Cervi, n.12, 1990, pp. 48-51
10) Amalia Signorelli, Il pragmatismo delle donne. La condizione femminile nella trasformazione delle campagne, in Storia dell’agricoltura in età contemporanea, vol. II Uomini e classi, Marsilio, Venezia 1990, pp. 638-639
11) Gianluigi Della Valentina, Il lavoro femminile nel Bergamasco di fine Ottocento, in Donna Lombarda 1860-1945, a cura di A. Gigli Marchetti e N. Torcellan, Franco Angeli, Milano, 1992
12) Nuto Revelli, L’anello forte, Einaudi, Torino, 1985, pp. 39-40
13) Annarita Buttafuoco, Introduzione a Donna Lombarda, cit. p.10
